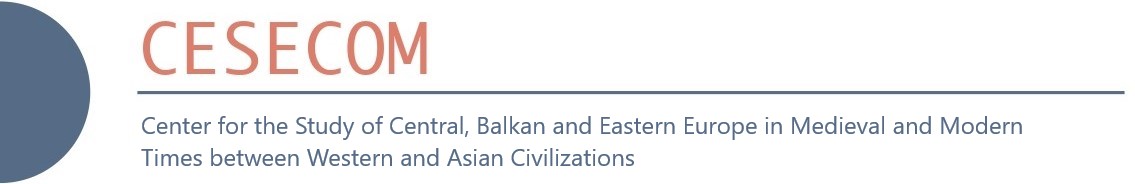Shepard J.
The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492
A cura di Shepard J. - Cambridge University Press, Cambridge 2009
Molte
strade portano a Bisanzio: verso la “Nuova Roma” convergono gli
interessi di numerose discipline, dall’archeologia alla storia
dell’arte, dalla teologia alla paleografia. Molti studiosi, anche se
partiti da obiettivi di ricerca apparentemente lontani, giungono spesso
alla necessità di conoscere e di confrontarsi con Bisanzio, sia che si
occupino di medioevo occidentale sia che si occupino di mondo
mediterraneo o di mondo slavo. Questo volume, grazie all’ampiezza
dell’arco cronologico considerato e ai ricchissimi riferimenti
bibliografici, il tutto unito a una impostazione tradizionale, si offre
perciò come un utile strumento di informazione e di aggiornamento per
tutti coloro che vogliano avere un approccio ampio alla storia di
Bisanzio. Il taglio della trattazione infatti, per ammissione dello
stesso curatore, “should yeld some fresh insights to specialists in,
and postgraduate students of, the Byzantine world. But it also has
something to offer newcomers to the enigma variations of Byzantium”(p.
2). Per consultare il corposo volume, di circa un migliaio di pagine,
non è richiesta quindi una conoscenza pregressa della disciplina, anzi
lo sforzo degli autori è stato proprio quello di offrire le linee guida
sulla storia di Bisanzio per un pubblico di lettori quanto mai vario,
ma soprattutto per un pubblico di lingua inglese. Come dimostra anche la
guida alle fonti in traduzione inglese – inserita nella parte finale
dell’introduzione - la priorità linguistica è stata determinante in
questa iniziativa editoriale, che si pone nel solco della tradizione
delle grandi opere storiche di Cambridge.
Il problema di rendere più accessibili le fonti medievali
attraverso una buona versione nelle lingue moderne è del resto di grande
attualità, come dimostrano le sempre più numerose iniziative di
edizione critica e traduzione di testi che negli ultimi anni si sono
moltiplicate soprattutto a fini didattici. Tuttavia questo fervore ha
toccato solo in parte il nostro paese, e dunque gli studiosi italiani,
quando non possono accedere direttamente al greco o alle altre lingue
usate dagli scrittori bizantini, sono spesso costretti a riferirsi a
traduzioni in altre lingue moderne, soprattutto l’inglese e il
francese.
La struttura del volume può definirsi tradizionale, nel senso che
i contenuti sono stati organizzati in tre sezioni, seguendo cioè la
tripartizione classica della cronologia bizantina: il periodo iniziale
della storia di Bisanzio, che significativamente prende le mosse
dall’epoca giustinianea (The earlier empire. 500-700); un
secondo periodo che, partendo dall’età iconoclasta, arriva a comprendere
i secoli centrali dell’impero fino alla Quarta Crociata (The
middle empire. 700-1204) e una terza parte in cui, più che a
un’idea ormai astratta di impero, ci si riferisce piuttosto al concetto
di “terre bizantine” nel senso di quei territori, città e popolazioni,
ancora saldamente legati alle strutture sociali, economiche e culturali
di Bisanzio (The Byzantine lands in the later middle ages.
1204-1492). Inusuale, ma interessante, è peraltro la data di
chiusura, che si spinge ben oltre il 1453 e arriva fino al 1492, con
uno studio di A. Bryer, The Roman orthodox world (1393-1492),
volutamente concentrato più sugli aspetti culturali e religiosi che
non su quelli propriamente storico-politici. La scelta si pone
giustamente a rappresentare uno spazio mediterraneo che, sebbene ormai
quasi completamente dominato dai Turchi, era ancora caratterizzato da
una significativa presenza della cristianità ortodossa ed era
costellato di importanti istituzioni religiose che godevano del
patrocinio di principesse cristiane mogli di sultani - come Mara
Brankovic (1412-1478), figlia dell’ultimo despota di Serbia e seconda
moglie di Murad II, e Maria di Doubera, matrigna del sultano Suleiman I
(1520-66) – nel segno della coesistenza e della continuità delle due
tradizioni religiose.
Nella scelta dei contenuti, oltre che nella struttura, si osserva
dunque una volontà di percorrere una strada decisamente più ristretta
rispetto all’analoga opera pubblicata da Cambridge negli anni Sessanta
ovvero The Cambridge Medieval History, vol. IV: The
Byzantine Empire, Cambridge 1966-67 (trad. it. Storia del
mondo medievale, vol. III: L’impero bizantino, a cura di
J. M. Hussey, Milano, Garzanti, 1983). In questo volume, che si può
considerare a tutti gli effetti l’antesignano dell’attuale, le sezioni
seguivano uno sviluppo molto diverso. Oltre a una serie di contributi
attorno alla storia politica, militare ed ecclesiastica dell’impero
bizantino a partire dal secolo VIII, vari capitoli erano dedicati alla
definizione delle caratteristiche dei popoli e dei poteri sorti attorno a
Bisanzio e da essa fortemente influenzati. La seconda parte di quel
volume inoltre si articolava in utilissimi capitoli tematici dedicati
ad aspetti della civiltà bizantina, quali la legge, il governo, la
chiesa, la musica, le arti visive e la letteratura.
Nel volume attuale invece l’approccio tematico, che a una prima
occhiata potrebbe sembrare del tutto assente, è stato realizzato
attraverso una linea interna ai contributi stessi. Già nella terza parte
dell’introduzione, infatti, si accenna alle nuove tendenze degli studi
e agli approcci alternativi alla disciplina: tale tendenza si evince
poi dalla qualità e dalla struttura dei contributi stessi del volume.
In definitiva, l’approccio tematico è realizzato all’interno della
trattazione e non nella struttura esterna. All’economia, ad esempio, si
accenna in varie sezioni, sebbene le si dedichi un lungo studio (M.
Witthow, The middle Byzantine Economy (600-1204), alle pp.
465-492), mentre alle relazioni con la Slavia sono dedicati vari
contributi: S. Ivanov, Religious missions, pp. 305-332; P.
Stephenson, Balkan borderlands (1018-1204), pp. 664-691; A.
Ducellier, Balkan powers: Albania, Serbia and Bulgaria (1200-1300), pp.
779-802; M. Balard, Latins in the Aegean and the Balkans
(1300-1400), pp. 834-851.
Non viene meno allora l’attenzione verso le diverse società, élites
e poteri che a lungo termine si sono rapportate con Bisanzio, sebbene
manchi uno specifico contributo dedicato ai legami fra l’impero e le
terre di Rus, e ciò malgrado il curatore
sia uno specialista dell’argomento (cfr. gli studi di J. Shepard - S.
Franklin The Emergence of Rus, 750-1200, London and New York
1996, e più di recente J. Shepard (ed. by), The Expansion of
Orthodox Europe: Byzantium, the Balkans and Russia, Ashgated
Variorum, 2007). Due aree in particolare diventano invece i punti
focali del confronto: innanzitutto il rapporto di Bisanzio con
l’Occidente, analizzato sia negli aspetti politico-diplomatici (J.
Moorhead, Western approaches (500-600), pp. 196-220; e M.
McCormick, Western approaches (700-900) pp. 395-432) sia per
la colonizzazione bizantina della penisola italiana (T. S. Brown, Byzantine
Italy (680-876), pp. 433-464; G. A. Loud, Byzantium and
southern Italy (876-1000), pp. 560-582). L’altro fronte di
interesse precipuo è quello arabo, che trova spazio in due importanti
contributi: quello di L. Conrad, The Arabs to the time of the
Prophet, alle pp. 173-195, e quello di W. E. Kaegi, Confronting
Islam: emperors versus caliphs (641-c.850), alle pp. 365-394.
Si può dunque concordare con il curatore quando
sottolinea che per dimostrare l’impatto di Bisanzio su varie culture di
rilevanza mondiale, quali l’Islam, l’Eurasia, i mondi slavi e
l’occidente cristiano, l’importante è osservare e analizzare le
interazioni piuttosto che narrare ogni singolo dettaglio già conosciuto
nelle relazioni con un particolare Stato. “The importance of Byzantium
to neighbouring or newly forming societies and powers emerges more
clearly when their individual situations and needs are taken into
account” (p. 3).